Puoi ascoltare anche su SPOTIFY
Telmo Pievani (1970) è Ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche. Presso lo stesso Dipartimento insegna anche Bioetica e Divulgazione naturalistica.
Dal 2016 è Delegato del Rettore per la Comunicazione Istituzionale e la Divulgazione scientifica dell’Università degli studi di Padova. Dal 2017 al 2019 è stato Presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica, il primo filosofo della scienza a ricoprire questa carica. È Socio effettivo di molti Istituti ed Accademie scientifiche. Dopo gli studi di dottorato e post-doc negli Stati Uniti, dal 2001 al 2012 è stato in servizio presso l’Università degli studi di Milano Bicocca.
Da settembre 2022 Pievani è referente nazionale dello Spoke 7 (Biodiversity and Society: Communication, education and social impact) del National Biodiversity Future Centre (Centro nazionale 5 del PNRR).
La ricerca di Pievani si concentra su vari aspetti dell’evoluzione biologica, inclusa la teoria dell’evoluzione, la biodiversità, l’antropologia e l’epistemologia delle scienze della vita.
Tra i suoi libri più noti, si possono citare La vita inaspettata. Il fascino di un’evoluzione che non ci aveva previsto, che esplora l’evoluzione della vita sulla Terra in modo che sia accessibile ad un pubblico ampio, e Introduzione alla filosofia della biologia, che è un testo chiave per coloro che sono interessati alla filosofia della scienza biologica.
Nel suo ultimo libro La natura è più grande di noi. Storie di microbi, di umani e di altre strane creature (Solferino, 2022) Pievani scrive: “Se un giorno gli umani sparissero per qualche misteriosa ragione, in poco tempo, la biodiversità della fauna selvatica si riprenderebbe i suoi spazi”, e aggiunge, “è un pensiero rassicurante”.
Siamo sulla soglia della sesta estinzione di massa? Ne parliamo in questa video intervista che il Prof. Pievani ha voluto concederci.
Trascrizione dell’intervista
Alessandro Di Nuzzo: Professor Telmo Pievani, nel suo ultimo libro, La natura è più grande di noi, lei scrive: “Se un giorno gli umani sparissero per qualche misteriosa ragione, in poco tempo la biodiversità della fauna selvatica si riprenderebbe i suoi spazi. E aggiunge, è un pensiero rassicurante”. Ecco, professore, siamo davvero sulla soglia di quella che chiamano la sesta estinzione?
Telmo Pievani: Noi sappiamo che la specie umana è in una fase critica del suo rapporto con l’ambiente. Quindi immaginare l’assenza della specie umana ovviamente non è un auspicio, io non sono nichilista o misantropo. Al contrario, è una provocazione, è un gioco che hanno fatto peraltro già grandi scrittori, pensiamo alle Operette morali di Leopardi, a Guido Morselli, e tanti altri.
Questa volta possiamo farlo però con i dati scientifici: quindi è importante capire che l’assenza della specie umana per il pianeta sarebbe del tutto irrilevante, nel senso che la natura non è fatta per noi, l’evoluzione non è stata una lunga preparazione all’arrivo di noi Homo sapiens. Questo ci fa fare un bel bagno di umiltà, secondo me, che è molto importante per impostare anche una giusta attitudine ambientalista o ecologista.
Bisogna capire che la natura è più grande di noi, che c’era prima di noi e che ci sarà anche dopo. Questo per me non è qualcosa di disorientante o di negativo, perché se capisci di non essere indispensabile capisci anche la grande fortuna che hai avuto, la fortuna che ha avuto la specie umana di nascere su questo meraviglioso pianeta e di avere una chance di conoscerlo, di studiarlo, di vivere, di tramandare le proprie conoscenze alle generazioni successive. Diciamo che è un esercizio provocatorio per favorire un impegno etico lungimirante per le generazioni future.
Perché è vero, siamo dentro una grande estinzione di biodiversità. Qualcuno metaforicamente la chiama la sesta estinzione, perché ce ne sono già stati cinque in passato molto gravi. Furono dovute in quel caso a fenomeni naturali, impatti di asteroidi, oscillazioni terrestri, eruzioni vulcaniche. Là era la natura nella sua violenza, nella sua potenza, a portare ogni tanto questi grandi scombussolamenti che hanno provocato l’estinzione anche di due terzi di tutte le forme di vita.
Qualcosa di analogo sta succedendo anche adesso, perché, se noi paragoniamo i ritmi di estinzione in corso adesso, vediamo che sono equivalenti a quelli delle grandi estinzioni del passato. Con due differenze fondamentali. Primo, quella di oggi è un’estinzione molto più veloce, quella che ha portato all’estinzione quasi tutti i dinosauri tranne quelle tre famiglie che sono diventati gli uccelli, è durata migliaia di anni, 300 mila anni. Mentre adesso questa riduzione dura pochi decenni, pochi secoli, quindi una velocità pazzesca mai vista prima. E poi rispetto a tutte quelle del passato è dovuta alle attività di una sola specie, la nostra. Queste sono due differenze importanti che dobbiamo sempre tenere presente.
Alessandro Di Nuzzo: Nel suo libro lei scrive: le pandemie sono un capitolo della crisi ambientale.
Ora, in questi anni di Covid noi in realtà abbiamo sentito molti che invece negavano con forza questo legame.
Telmo Pievani: Sì non c’è dubbio, lo dicono le più grandi riviste scientifiche al mondo, lo hanno ripetuto tante volte. Perché? Perché durante l’emergenza è chiaro che quello che bisogna fare è fronteggiare l’emergenza stessa: quindi igiene, distanziamento sociale ecc. Dopo nove mesi, sono arrivati i benedetti vaccini e ne siamo usciti, con grandi sofferenze, con grande fatica.
Ricordiamo sempre che non abbiamo vaccinato tutti, ma solo la parte più ricca del mondo; quindi, c’è anche un elemento di ingiustizia che va tenuto presente. Ma adesso stiamo facendo un errore gravissimo, che è quello di dimenticare le ragioni profonde, ecologiche, di quello che è successo. Perché è vero che le pandemie ci sono sempre state, e sempre ci saranno. Ci sono dal Neolitico in avanti, perché sono legate al contatto tra animali portatori di microbi, virus e batteri, e gli esseri umani. Ma non dimentichiamo l’altro lato della questione: cioè che dagli anni 80 circa oggi il numero di pandemie è aumentato esponenzialmente.
Non può essere un caso. Perché sono aumentate così tanto? Perché ci sono delle ragioni ulteriori che rendono più probabili le pandemie. Quali sono queste ragioni? La deforestazione; i wet market, cioè questi mercati dove le condizioni igieniche sono pessime, tremende, con animali vivi, morti, mescolati insieme, i liquidi corporei che si mescolano, un disastro dal punto di vista igienico; il commercio illegale di animali esotici; la sostituzione delle foreste con le piantagioni. Queste sono tutte concause che rendono più probabile che ci siano zoonosi, cioè salti di specie. Perciò la pandemia ha a che fare con il cambiamento climatico ed è l’ennesimo sintomo di un rapporto malato tra la specie umana e l’ambiente.
Ricordiamoci che la probabilità che succeda un’altra pandemia non è diminuita dopo che siamo usciti dalla pandemia da Covid-19: è rimasta la stessa che c’era nel 2019. Ecco perché dovremmo imparare a essere più previdenti, più capaci di fare prevenzione e non aspettare tutte le volte di trovarci davanti al fatto compiuto e trovare i vaccini, ma lavorare preventivamente per ridurre il rischio che succeda di nuovo. E questo non lo stiamo facendo.
Alessandro Di Nuzzo: Professore, lei ricorda nel suo libro che l’Italia resta miracolosamente la nazione con la più alta biodiversità di piante e animali in tutta Europa. Noi siamo da millenni un laboratorio di diversità. Ecco, ci dica tre vantaggi – o anche quattro, cinque – fondamentali per la nostra vita della biodiversità.
Telmo Pievani: Questo è un tema fondamentale. Innanzitutto, ricordiamoci perché siamo così fortunati: non è un merito nostro. Viviamo in un Paese che ha una biodiversità strepitosa, altissima, che batte di gran lunga quella di Paesi come la Francia, la Germania, persino i Paesi nordici. Perché? Perché siamo un Paese particolarissimo. Abbiamo due catene montuose quasi perpendicolari: questo vuol dire tante barriere ecologiche, tante differenze. Dalla punta della Sicilia al Bellunese abbiamo 132 ecosistemi diversi, il che vuol dire suoli diversi, piante diverse, animali diversi, un’enorme e meravigliosa diversità di ecosistemi e quindi di esseri viventi.
E in più, altro motivo di diversità meravigliosa, siamo una zona di passaggio. Di migrazioni da sempre, da sud, da nord, da est a ovest. Perciò se noi mettiamo insieme tutti questi ingredienti, il risultato è un luogo ricchissimo di biodiversità.
E perché ci fa tanto bene questa biodiversità e non dovremmo ridurla? Per tante ragioni. Primo, perché ci dà dei servizi ecosistemici che garantiscono la nostra vita, la nostra salute e che non paghiamo. I nutrienti dei suoli, la fertilità dei suoli, gli insetti impollinatori che garantiscono gran parte delle nostre coltivazioni, quasi due terzi.
Questi sono servizi gratuiti che ci offre la natura. Poi, perché dentro la biodiversità ci sono delle ricchezze inestimabili: principi attivi per nuovi farmaci, nuovi materiali sostenibili che possiamo scoprire. L’ultima gomma ecosostenibile che è stata scoperta, con cui facciamo i jeans ecosostenibili, è stata trovata in una pianta, non in Italia, in questo caso in Brasile – ma non importa, il principio è che la biodiversità è piena di risorse che ci fanno bene.
E poi perché la biodiversità è la difesa principale dal climate change, perché se noi manteniamo le piante, che sono delle macchine che assorbono CO2, e manteniamo in salute gli ecosistemi, riusciamo anche ad attutire, a mitigare, a ridurre un po’ i costi del riscaldamento climatico. Ne ho scelte tre, ma avrei potuto scegliere tante altre. Insomma, non ci conviene ridurre questa ricchezza meravigliosa sopra la quale camminiamo spesso inconsapevoli.
Alessandro Di Nuzzo: C’è un’immagine molto bella nel suo libro, quando dice che, per uscire dalla drammatica crisi ambientale, servono decisori politici nazionali e internazionali che abbiano il pensiero delle cattedrali, cioè il pensiero dei costruttori medioevali.
Ora io le chiedo: lei ritiene che l’umanità, i leader politici attuali, per esempio, siano in grado di avere o di ritrovare questo pensiero delle cattedrali?
Telmo Pievani: Beh, il pensiero delle cattedrali è indispensabile, ed è qualcosa che in fondo non abbiamo mai perso, anche se è rimasto un po’ sottotraccia. Vuol dire impegnarsi per compiere un’opera, come facevano gli architetti delle cattedrali medievali, che tu sai benissimo che non vedrai finita. L’avrebbero vista finita forse i loro figli, forse i loro nipoti, perché richiedeva uno sforzo transgenerazionale. Ecco, il climate change, la difesa della biodiversità sono cattedrali, richiedono un impegno oggi affinché degli effetti positivi siano goduti dai nostri figli e dai nostri nipoti.
Il pensiero delle cattedrali richiede lungimiranza e altruismo, generosità: perché vuol dire che non godrò io del mio impegno, delle mie azioni, ma ne godranno coloro che verranno dopo di noi. certo è difficile politicamente; però ricordiamoci che l’Italia con tutti i suoi difetti un pensiero delle cattedrali lo ha esibito l’anno scorso. Nel febbraio del 2022 è stata cambiata la Costituzione italiana, nell’articolo 9 e nell’articolo 41, quello che regola la libertà di impresa.
Per la prima volta nella storia repubblicana è stato cambiato un articolo fondamentale, aggiungendovi un comma essenziale: la Repubblica Italiana tutela l’ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità, anche nell’interesse delle future generazioni. Questo è il pensiero delle cattedrali: scrivere un articolo della Costituzione che dice che io devo difendere l’ambiente nell’interesse di chi non c’è ancora, di chi ancora non è un soggetto giuridico. Un bellissimo esempio di pensiero delle cattedrali. Quindi, volendo, ne siamo capaci.
Faccio un altro esempio semplice, che si è concretizzato qualche mese fa. Oggi quasi nessuno parla più del buco dell’ozono. Perché? Perché la politica internazionale negli anni Ottanta ha scritto un protocollo, il Protocollo di Montreal, che, pur con grandi difficoltà, è stato accettato da quasi tutte le nazioni del mondo. Quel protocollo diceva alle aziende: dovete smetterla di immettere in atmosfera certi tipi di gas, i clorofluorocarburi, come quelli che vengono usati nelle bombolette o nei frigoriferi.
Ci è voluto tempo, sono state cambiate le filiere industriali, abbiamo imparato a fare le bombolette e il frigorifero in modo più intelligente; sono passati più di trent’anni, e nel 2022 finalmente la scienza ci dice che il problema del buco dell’ozono è stato in gran parte risolto. Trentacinque anni. Sono sette legislature, mediamente.
Quello è il pensiero delle cattedrali. Si è presa una decisione, e la politica ha condizionato il mercato. Abbiamo dovuto aspettare 35 anni, ma alla fine vediamo risultati positivi. Volendo si può.
Certo ci vogliono politici che abbiano lungimiranza e tanto altruismo verso le generazioni future: e in questo momento, purtroppo, non li vediamo.
Alessandro Di Nuzzo: Professore, è possibile che ci sia un nesso fra i cambiamenti climatici e l’evoluzione? Voglio dire, l’evoluzione della specie umana, per esempio, può interagire con i cambiamenti climatici?
Telmo Pievani: L’evoluzione umana ha sempre interagito con il riscaldamento e il raffreddamento climatico, con il cambiamento del clima. Questo è un fatto paradossale, ma molto interessante.
Noi non saremmo qui se il clima non fosse cambiato. Noi siamo proprio figli di una storia evolutiva, quella degli ultimi due milioni e mezzo di anni, in cui il clima è sempre cambiato. Fasi fredde, fasi glaciali, fasi interglaciali, continue oscillazioni che portavano le fasce di vegetazione a spostarsi. Noi inseguivamo le risorse, per adattarci ai cambiamenti climatici. Quindi, per esempio, siamo nati in Africa e siamo andati in giro per il mondo.
Abbiamo colonizzato tutta l’Eurasia a causa dei riscaldamenti, dei cambiamenti climatici. Noi siamo figli di questa instabilità ecologica che riguarda il pianeta, ripeto, da moltissimo tempo: due milioni e mezzo di anni. E molto della nostra creatività, della nostra flessibilità, della nostra adattabilità e anche la mobilità stessa, cioè il migrare, sono proprio un adattamento fondamentale al climate change.
Tutto questo però non deve portarci a pensare che ciò che sta succedendo oggi, in fondo, è sempre successo – e allora chi se ne importa, è una normale dinamica evolutiva. Perché, come dicevamo prima, quello che sta accadendo adesso ha degli elementi particolari: il clima sta cambiando in modo molto più veloce che in passato, e inoltre mentre in passato cambiava per conto suo, adesso cambia a causa delle attività umane.
Adesso dico una cosa che sembra un paradosso, ma è così. Il fatto che questa volta il cambiamento climatico dipenda da noi è da un lato un fatto negativo, perché vuol dire che siamo noi i responsabili: ma provate a pensarci, può anche essere la nostra speranza. Perché se, come qualcuno dice pensando di cavarsela con questo, il cambiamento climatico fosse dovuto a dei cicli naturali, al sole, ai vulcani, all’orbita terrestre, non ci sarebbe niente da fare. Cioè saremmo disperati: visto che noi non possiamo cambiare i vulcani, il sole, l’orbita terrestre. Vuol dire che non potremmo fare nulla.
Invece, il fatto che la scienza ci dica che è dovuto alle attività umane, significa che possiamo fare qualcosa. Se cambiamo quelle attività e facciamo una vera transizione ecologica, il clima smetterà di andare verso il riscaldamento insostenibile e ci fermeremo a un grado e mezzo, due gradi. Dunque noi possiamo fare la differenza. In questa evidenza, cioè che il riscaldamento attuale è antropico, c’è la differenza rispetto al passato, e c’è anche una speranza per il futuro.
Alessandro Di Nuzzo: Un’ultima domanda, se vuole più personale. Perché secondo lei, al di là delle parole, delle professioni d’intenti, delle dichiarazioni a favore dell’ambiente, noi – dico la specie umana – facciamo tanta fatica a mettere in pratica i comportamenti e le decisioni a favore dell’ambiente, della salvaguardia della natura – e quindi della nostra salvaguardia. Perché siamo così autolesionisti?
Telmo Pievani: La sfida ambientale è obiettivamente una sfida difficile. Io non voglio giustificare nulla e nessuno: però lo è oggettivamente. Da un lato la scienza ti mostra delle evidenze che ti stanno dicendo che devi cambiare la tua vita, che devi cambiare i tuoi valori. Niente di rivoluzionario, di terribile: però vuol dire che bisogna mettersi nell’ottica di cambiare il modo di mangiare, di comprare le cose al supermercato, di viaggiare, la macchina che usiamo, quanta carne rossa mangiamo, eccetera eccetera. La scienza per così dire ci entra in casa e ci fa un po’ i fatti nostri. Questo ci dà fastidio obiettivamente, dobbiamo essere sinceri. Però dobbiamo ascoltarla assolutamente se vogliamo, ripeto, salvaguardare il futuro dei nostri figli.
Poi ci sono degli interessi economici fortissimi che vengono minacciati da questo cambiamento: ma che secondo me piano piano verranno superati, perché anche le aziende cominciano a capire che fra dieci anni i gusti dei consumatori saranno diversi, le loro consapevolezze saranno diverse. Quindi si stanno preparando, ben prima della politica secondo me, a fare questa transizione. Intanto però ci sono fortissimi interessi sui combustibili fossili, che rallentano e che seminano dubbi ingiustificabili: anche per questo stiamo facendo una gran fatica.
E poi, ultimo motivo, questo è un problema grande, complesso, e che si presenta in modo non lineare. Fa freddo, fa caldo, piove tanto, piove poco, lunghi periodi di siccità, poi alluvioni. Sono cose che ci sconvolgono, che ci disorientano, che riguardano a volte paesi lontani, a volte noi, che accadono improvvisamente in modo imprevedibile. In realtà sappiamo che la probabilità che accadano è sempre maggiore. Insomma, come dicono i miei colleghi, è un oggetto strano, il climate change: è un iperoggetto, difficile da afferrare tutto in una volta.
Ci vuole immaginazione, ci vuole capacità di astrazione e di lungimiranza verso il futuro. E’ una sfida anche per la nostra mente, proprio per le nostre capacità cognitive.
Se tu metti insieme tutti questi aspetti – quelli economici, quelli della nostra vita, quelli cognitivi – alla fine è difficile. Però dobbiamo farcela.
In fondo, siamo sopravvissuti anche a momenti anche più difficili in passato, e abbiamo tirato fuori il meglio di Homo Sapiens: ovvero la sua capacità immaginativa.
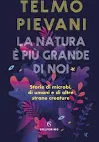
Sito del Prof. Pievani
Il link al nostro podcast: QUI
Trascrizione dell’intervista